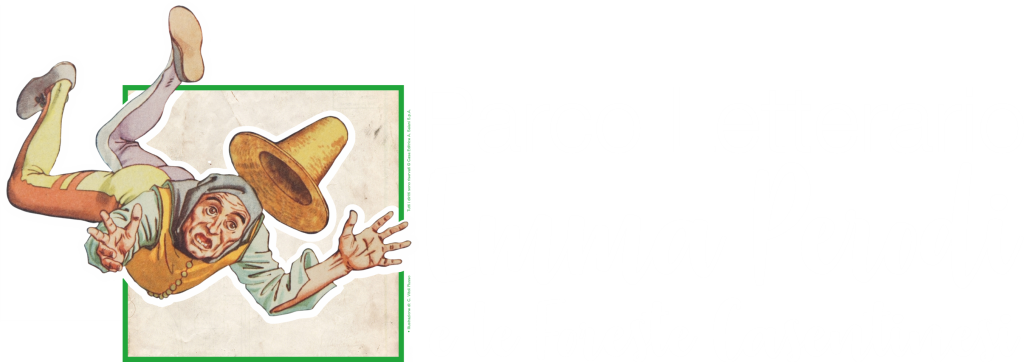Esistono le fate? Noi le abbiamo incontrate in un loro bosco incantato che circonda, pensate, il Santuario della Verna. Sì, proprio là, in quel luogo sacro di incomparabile bellezza e verità. Suggestione, mi si dirà. Nostalgia dell’infanzia. D’accordo. Reminiscenza di antiche novelle. Senz’altro. Eppure, ve lo assicuro, le abbiamo riconosciute. Si erano appena svegliate nell’incanto dei colori del fuoco e dell’oro, ridestate dal sole fulgido di un mattino ancora caldo d’ottobre. Sostavano impalpabili, leggere pronte a librarsi in volo all’ombra di quei faggi secolari loro amici, numi tutelari di un più vasto cosmo, sospeso tra terra e cielo, la cui intelligenza risplende non ancora pienamente svelata. Camminando in quel loro regno dimentico del tempo, dove vita e morte si riconciliano tessendo mirabili equilibri che danno vita a nuove creature, ci siamo sentiti parte di una natura che ha il volto di un’amante, per altri di madre generosa e saggia, vicina alle fonti della fecondità e del rinnovamento. Come lo sono le fate. L’incontro così propizio, qui sommariamente richiamato, lo dobbiamo all’iniziativa del Parco Letterario “Emma Perodi” che, insieme al Parco delle Foreste Casentinesi, ha recentemente promosso un convegno sulle foreste sacre preceduto da una visita guidata al bosco delle fate. Grata di questa loro intelligente e articolata iniziativa, ripropongo un breve viaggio alla riscoperta di queste figure dimenticate o relegate a nutrire solo l’immaginario del bambino.
Un tempo, queste creature femminili così affascinanti e prodighe di doni non erano così lontane dalla nostra vita, non solo per l’uomo colto – partecipe dei domini dell’universo letterario, annoverante dal XII° secolo in poi una vasta serie di racconti immaginari, lai, romanzi, fiabe che accoglievano la fata, al centro della scena, ad ordire eventi e mutamenti – ma anche per l’uomo di strada che ritrovava nel suo viaggio, fra orizzonti noti, indizi e attestazioni certe di una loro presenza sebbene sempre celata e misteriosa.
Lo testimoniano tanti toponimi che sono giunti fino a noi quale specchio di una cultura che per secoli ha riconosciuto nella natura, animata da forze segrete, una soglia aperta all’anima, all’universo e al mistero, al sacro.
Varcati gli incerti confini delle città, che sempre più si espandono tentacolari unendosi in spazi metropolitani, capita, infatti, ancora oggi di imbattersi in luoghi chiamati bosco – altrove balzo, sorgente, fonte – delle fate. In quegli spazi è benefico sostare in una frazione sottratta al tempo ordinario, mentre suoni leggeri in movimento invitano all’ascolto e la meraviglia della visione ci apre alla contemplazione.
La toponomastica attesta quanto fiabe e racconti descrivono con più dovizia: è il bosco il regno da cui la fata proviene, prodigo di esseri e doni, rigoglioso e verdeggiante nel cerchio del tempo che muta, ma che pare iscritto nell’eterno. L’acqua, fonte ed origine, filtra nel suolo fra radici e humus affiorante, alimenta le sue sorgenti nascoste, protegge le piante secolari e i germogli di quel regno silvano. E dell’acqua, sua culla e dimora, la fata possiede lo splendore iridato, la mutevolezza del canto, il rigenerante potere.
Oscilla sempre la fata, divina creatura, fra luce e ombra, anche quando sceglie, con giovanile baldanza, come propria dimora, le sorgenti di fiumi. Lì, regale, compare, col suo manto che abbaglia, quando libera corre col sole, poi torna con luce di perle la notte, accompagnata da ombre, cupi riflessi di umide rive e di fronde di alberi vibranti nel vento. Poeti e viandanti in cerca di sogni, nel contemplare lo specchio immoto di laghi, l’hanno intravista aggirarsi, nello splendore di giorni d’estate, entro castelli incantati immersi nell’oscurità di acque profonde, o posarsi seducente sulla superficie increspata e limpida di specchi racchiusi fra monti.
Signora della metamorfosi, talvolta si eclissa e balza sulle cime delle montagne, là dove si interrompono i sentieri e lo sguardo si volge a distese senza confini o all’abisso che suscita brividi e stupore.
Dovunque provenga, la fata ci invita a rivisitare i suoi spazi ormai minacciati dall’invadenza omologante dell’oggi. Possiamo raggiungerli camminando lentamente mentre si medita oppure possiamo accoglierli e proporli al nostro sguardo interiore mediante l’arte, il sogno, la reverie.
Nelle voci del bosco, nel muschio silente, nell’impeto di ruscelli scroscianti, o altrove, là dove, come c’è detto, si aggira o sosta una fata, l’Io ritrova un rinnovato respiro, più vasto, di vento, di onde marine; lì un equilibrio, che si concede tempo e ascolto, si ricompone e ridona energia in una nuova visione di sé e del mondo alleata al possibile e all’invisibile.
L’apparizione della fata è infatti metafora del passaggio numinoso dell’Anima nella coscienza, da sempre avvertito come illuminazione, rivelazione, ispirazione salutare, generante la trasformazione, il cambiamento radicale.
Un primo mito greco (qui non si parlerà della fata amante soprannaturale, nè di lei come epitome della Grande Dea) è rintracciabile nel nome e nelle prerogative attribuite alle fate, il mito delle Moire, dee del fato, Parche per i Latini, che decidono la sorte degli uomini al momento della loro nascita. La fata è l’artefice del destino inteso come opera delle grandi tessitrici: appartiene alla sfera del sacro che trascende questo mondo ma che in questo mondo si manifesta, attualizzandone tutte le sue potenzialità. La fata rappresenta la creatura che entra in contatto con i misteri della psiche che conducono ad una sapienza che riguarda sia l’anima sia il mondo, così svolge l’importante funzione di smuovere il soggetto da una sterile immobilità e fedeltà al passato verso nuovi orizzonti e profondità. Con il suo intervento libera dalle ossessioni egocentriche, perchè risveglia in chi ha la ventura di incontrarla – complici il desiderio e il riconoscimento di una propria crisi – una più vasta coscienza di sè e della vita, aperta all’universo.
Conoscere i luoghi d’elezione, prescelti dalle fate come propria dimora, seguendo il genius loci o i racconti tramandati, significa allora immettersi entro un itinerario circolare: ne segna l’avvio il fascino sprigionato dalla natura che pulsa nella sua maestà, nel suo ritmico ciclo che connette la vita e la morte per far rifiorire la vita, ma questo stesso senso di meraviglia che giunge ad innervare gli spazi segreti dell’anima, dando avvio ad un movimento espansione, ci riconduce in modo nuovo a quegli stessi luoghi da cui siamo partiti e ci fa riconoscere la natura come linfa per il presente, madre e maestra, affermando una visione sacra della terra in gran parte perduta.
La sua presenza si riconnette alle visioni altre del mondo e del pensiero, a quanto è rifiutato, rimosso, marginale rispetto alla cultura di referenza e ci permette di riscoprire che anche i luoghi hanno ricordi, custodiscono saperi, hanno un’anima. Questo ci ripropone la necessità di porre in primo piano, in modo chiaramente problematico il nostro rapporto con la natura, recuperando il concetto di luogo nella sua complessità. Riscoprire e reinterpretare la memoria dei luoghi è il primo atto di ricostruzione di momenti comunitari nel riconoscimento dei beni comuni, ma è al contempo un cammino che porta al reincanto, alla cura quale scelta fondamentale che tende ad affermare un’immanentistica visione sacra della vita che mantiene viva la tensione verso l’alterità e le qualità di un sapere erotico. Si tratta di un sapere che, come l’Eros descritto da Platone, unisce instancabilmente l’umano e il divino, la materia e lo spirito, la terra e il cielo; e che non perde, nel percorso verso l’alto, il rapporto con l’origine, con la matrice materiale da cui proviene. Infatti riafferma la connessione e interrelazione tra tutti gli esseri viventi nel superamento del divorzio tra l’uomo e la natura. In questa ottica la valorizzazione di eredità lontane che passano attraverso la riscoperta dell’immaginario e di un insieme di figure archetipiche di cui la fata fa parte, feconda il pensiero e dà voce e vigore ad una dimensione etica della vita con il senso di responsabilità che l’accompagna.
La fata, che in tante fiabe ancora ci parla con semplici parole, cela, come sosteneva Italo Calvino, l’essenza della filosofia intesa come ricerca della sapienza, quale ordine superiore di un sapere che, (seguiamo le parole di Nietzsche), «senza farsi ingannare dalle seducenti deviazioni delle scienze, si rivolge con sguardo immobile al quadro globale del mondo e in esso cerca di cogliere, con un sentimento di amore compassionevole, l’eterna sofferenza come sofferenza propria» un sapere che rivela la sua efficacia nel momento delle scelte fondamentali quelle che determinano la rotta, il destino sul piano personale e sociale.
In questa ottica il rapporto tra letteratura e natura può conoscere una nuova stagione ancora in parte da esplorare. Alla Verna con il Parco Letterario Emma Perodi abbiamo scoperto quanto è benefico sostare nei luoghi amati dalle fate che interrogano da lontano il nostro mondo disincantato, con il fascino del loro carattere sorgivo.
Carla Beatrice Lomi