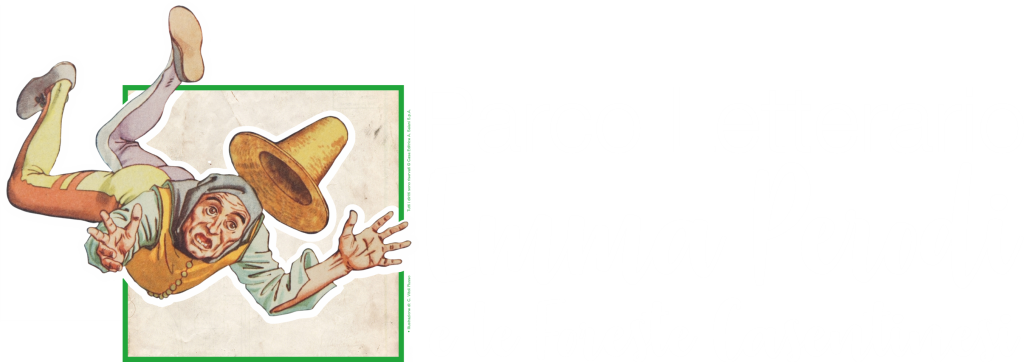“Il castello di Poppi gli apparve da lontano, alto sulla piana dell’Arno, sentinella sul fiume e sulla via di Bibbiena”. L’11 giugno 1289 l’oste guelfa da Firenze e i ghibellini di Arezzo avrebbero impugnato le armi nella piana di Campaldino
“Il castello di Poppi gli apparve da lontano, quadrato ed elegante insieme, alto sulla piana dell’Arno, sentinella sul fiume e sulla via di Bibbiena; una fitta rete di orti e campi coltivati disegnava la pianura attorno al suo cavallo; il bosco che veste il pendio del colle pareva, in quell’inizio di giugno, un fresco nido di fronde nel quale il borgo riposava al sole, disteso sul breve crinale che va dal castello alla sagoma dell’abbazia di San Fedele, protettiva come una chioccia coi suoi pulcini”.
Poppi è centrale in qualsiasi narrazione della battaglia.
“Alla prima ora del venerdì il sole indorò le pietre del castello. Dalla finestra aperta sul muro orientale la luce del mattino penetrò nel salone al primo piano, allungando una scia sul pavimento e sul tavolo. Le pareti affrescate, la travatura del soffitto, il legno delle cassepanche e la pietra del grande camino assunsero un’aura diafana, quasi sacra. Mauro, però, chiamato alla riunione dei capitani dell’oste ghibellina, vi trovò un’atmosfera tutt’affatto diversa”.
Il giorno dopo, 11 di giugno del 1289, sabato di san Barnaba, l’oste guelfa messa in campo da Firenze e i ghibellini di Arezzo guidati dal vescovo Guglielmino avrebbero impugnato le armi nella piana di Campaldino.
Fu battaglia cruenta: in poche ore lasciò sul terreno 2.700 cadaveri e segnò la disfatta ghibellina.
Battaglia cui s’erano opposti perfino gli astri: quel giorno, infatti, “Giove, cioè il partito guelfo, dominava il cielo, mentre Saturno, che rappresentava i ghibellini, si trovò in una zona che gli antichi indicavano come la fine della vita, in perfetta quadratura col Sole, a significare la perdita del potere, e Antares fu vista sorgere sull’orizzonte orientale di Campaldino, portatrice di violenza e morte”.
Battaglia che il vescovo aretino aveva cercato di evitare intavolando una difficile trattativa coi priori di Firenze. Al centro dei colloqui le ferriere del Casentino e le fucine dei fabbri di Bibbiena, centri moderni ed efficienti per la produzione di armi. Il negoziato, però, fu fatto fallire dai nobili aretini, primo fra tutti Guido Novello, conte di Poppi e podestà di Arezzo, il quale poi s’accordò segretamente lui coi fiorentini ed abbandonò il campo nel momento decisivo dello scontro.
Battaglia cui parteciparono pure gli elementi. Quando “la campana dell’abbazia di Strumi, di là dall’Arno, batté l’ora terza d’una giornata già calda, il vento di libeccio spinse grosse nubi sui prati sommitali del Pratomagno. «Pare che ci vengano addosso» mormorò Ghigo mentre il vescovo dava il segnale dell’attacco”.
All’ora sesta, mentre la battaglia infuriava e Guglielmo Pazzo moriva nell’assalto al carroccio di Firenze, “i nembi calarono a coprire i boschi sopra Borgo alla Collina”.
“Un lampo squarciò l’aria, il tuono fece tremare la terra e mise le ali al destriero di Buonconte da Montefeltro, che portava il suo padrone lontano da quella follia, a morire sulle rive dell’Archiano”.
“Ancora un lampo, un altro tuono s’allontanò verso la Verna in un brontolio sinistro, mentre Guido Novello lasciava il campo senza combattere”.
Ed infine “i rintocchi di Strumi scandirono l’ora nona ed il temporale si scaricò violento sulla piana, spegnendo l’afa e le speranze dei ghibellini proprio nel momento in cui il vescovo Guglielmino veniva trafitto”. S’era gettato nella mischia per morire con i suoi, dopo aver affidato a Mauro il proprio anello episcopale.
Il romanzo storico L’anello del vescovo, da cui sono tratte queste citazioni, narra proprio le vicissitudini del giovane Mauro dei Mauri, novello sposo strappato alla sua Berta per seguire il vescovo a Campaldino.
Scampato all’ecatombe, riuscirà a tornare ad Arezzo solo dopo aver toccato, uno dopo l’altro, alcuni ‘luoghi dell’anima’ incastonati nel versante casentinese del Pratomagno.
A Strumi si trova a dare ai superstiti quel coraggio che lui per primo sente di non avere. All’eremo del beato Torello gli viene chiesta una conversione interiore e si chiede quale peccato debba farsi perdonare. Tornato sulla via di fondovalle deve fare i conti con l’odio di fazione che lo obbliga a scontrarsi col capo dei guelfi aretini. Scampato verso Raggiolo osserva atterrito le distruzioni della guerra nella ferriera devastata, e sperimenta l’umiliazione d’esser ferito da una donna. In una radura tra i boschi una strega gli salva la vita e lo fa riflettere sulla follia degli uomini. Ripara infine a Santa Trinita in Alpe, autentico paradiso sui monti, dove apprende che spesso la realtà non è come appare.
Mauro dei Mauri, personaggio di fantasia, è il protagonista di un’epopea degli sconfitti, della rivalsa dei deboli caparbiamente cercata contro ogni logica e ottenuta dopo un percorso interiore che parte proprio dalla disfatta dei potenti.
La natura del Casentino, i suoi borghi, le abbazie, il castello di Poppi muto testimone della battaglia, le fiamme che avvolgono Bibbiena distrutta, non sono lo sfondo del romanzo ma partecipano alla vicenda, protagonisti e vittime essi stessi della tragedia, e fattivamente autori del riscatto dei vinti.
Attraverso il giovane Mauro il libro cerca di dar conto delle cause reali e ideali della battaglia di Campaldino, e delle sue conseguenze.
Mauro dei Mauri, in fondo non è un’invenzione ma sono io e, spero, ogni lettore, un po’ costretto e un po’ volontario di quell’epica battaglia che spesso è la vita. E profondamente reali sono i luoghi, sia quelli che hanno retto la sfida dei secoli e ci appaiono ancora oggi maestosi, sia gli altri, ridotti a tristi rovine e tuttavia autentici persistenti luoghi dell’anima.
Nanni Cheli